Il secondo romanzo di Nick Cave è un viaggio al termine della notte nell’abiezione suburbana, ma al termine della lettura manca una vera ragion d’essere dell’apologo o una reale evoluzione tragica del personaggio.
————————————————————-
“La pelle del suo volto è grigia come carta di giornale ridotta in poltiglia e le gengive sono chiazzate di un viola acceso, con denti grossi e marroni. Una melma di capelli incolori gli cola sulla nuca del cranio a forma d’uovo come intingolo di pollo”.
È una descrizione particolarmente ‘vivida’ del padre di Bunny Munro che appare verso il compiersi del suo tragico destino, quando il protagonista si reca col figlio a trovare il padre malato. Ma è solo un esempio: di descrizioni così, col cursore dello squallore spinto al massimo e bilanciate solo da un’ironia sarcastica e senza pietà, il secondo romanzo di Nick Cave (ed. Feltrinelli, pagg. 261, € 16,50) ne è pieno: sono i veri mattoncini del suo Lego.
Che Irvine Welsh, nel risvolto di copertina, paragona a una mischia di “Cormac McCarthy, Franz Kafka e Benny Hill insieme in un alberghetto del lido di Brighton”.
Io non so se questo sia un complimento sincero o “comprato”, ma comunque mi sembra abbastanza sbagliato. Non sono un fine conoscitore di McCarthy, che ho apprezzato finora attraverso lo sguardo filmico dei Coen, ma non mi sembra che il libro di Cave abbia la forza dei moderni “western filosofici di frontiera” dello scrittore del Tennessee, così come sono invece certo che Bunny Munro non sia una vittima di un sistema opprimente e spersonalizzante, come i grigi personaggi del Grande Praghese.
Forse Irvine Welsh è entusiasta del fatto che Cave tracci un quadro di brit-suburban-squallor non molto lontano dal suo Trainspotting, altro romanzo che io conosco solo attraverso lo sguardo filmico di Danny Boyle, quindi qui mi fermo.
Saranno forse le mie lacune letterarie, ma il paragone che mi sembra più calzante per definire la discesa agli inferi di Bunny Munro è quello di Bukowski.
Un protagonista moralmente abietto, immerso in un ambiente umano per lo più livido e squallido quanto la sua anima, un insistente ricorso al sesso (ben rappresentato dalla cover australiana del libro che vedete qui a destra) e all’alcool come carburanti per rimettere in moto ‘sto sacco di miserie – anche senza andare da nessuna parte, perché dall’inferno quotidiano non è data via d’uscita – mi sembrano tutte le coordinate salienti del Vecchio Porco californiano.
Il quale peraltro deve gran parte della propria fama a raccolte di racconti brevi, ancorché basati più o meno sempre sugli stessi temi. Sulla lunghezza delle 260 pagine, invece, la narrazione dell’Australiano a me è risultata un po’ ripetitiva: Cave si è sì scafato nell’impiego del linguaggio romanzesco e le sue situazioni sono appunto orride e divertenti insieme, come uno s’aspetta dall’autore del canzoniere della Mala Semente, ma alla lunga stancano. Il che nel pulp è peccato mortale. Se l’autore mi schiaffeggia ad ogni pagina a visioni di fighe, luride scopate e colpi sempre più bassi, e io mi trovo a dire “ok, possiamo passare oltre?”, vuol dire che qualcosa nel meccanismo non funziona.
Non dovrei restar lì percosso e attonito a chiedermi quanto di Munro c’è in me, in ognuno di noi meschini piccoli borghesi di mezz’età, terrorizzati di non esser più sessualmente attraenti per ogni passante femmina che incrociamo? Di non saper più strappar l’applauso col nostro solito numero piacione?
Sotto quest’aspetto, il brano letto da Stefano Benni nella serata al Dal Verme (la foto di Nick che legge qui a sinistra è attuale ma non relativa alla serata) – ossia l’incontro-scontro con la virago maestra di Tae Kwon Do e immune dalle lusinghe di Bunny – è effettivamente uno dei vertici ideali e di godibilità del libro.
Però mi rimane comunque un po’ d’amaro al fondo. Cave non è certo scrittore pulp “da stazione”: è uno che ambisce dir qualcosa, lo fa con le canzoni, l’ha fatto col primo romanzo e con la sceneggiatura di The Proposition per John Hillcoat (cui pare fosse destinato anche il soggetto Bunny Munro).
E ad un livello filosofico più alto richiamano del resto anche i numerosi elementi soprannaturali (secondo me quasi marqueziani) che compaiono lungo la storia: apparizioni del fantasma della moglie-mamma suicida, l’incombere della misteriosa e fatale betoniera (degna di Duel), le presenze demoniache avvertite o evocate da fatti di cronaca e persino gli sbuffi di vapore che Bunny emette come una moderna Linda Blair de L’Esorcista. Tutti presagi di un Destino Sommo, un punto d’arrivo inesorabile cui il protagonista è diretto, consapevolmente e senza resistenza.
Ma qual è dunque la méta di questo viaggio al termine della notte? Ecco, secondo me è proprio l’assenza di quella che un tempo si sarebbe detta “la morale della storia”, insieme all’assenza di evoluzione del personaggio, pur nella tragedia (il pàthei màthos), il vero punto debole del romanzo. Sembra che Nick abbia quasi timore di esplicitare la morale del suo viaggio morale. E dire che – a quanto pare – sembrava che in maturità avesse persino riaperto il dialogo con Dio…
Non vorrei ampliare troppo il discorso, ma forse questo è un problema che si può applicare anche ad altri scrittori pulp contemporanei: ad esempio a Joe R. Lansadale (un mio mito, di cui ho appena letto a perdifiato La Ragazza dal Cuore d’Acciaio). Forse che tutti noi pulpisti abbiamo paura di mostrare una pars construens nelle nostre storie, per tema d’apparire moralisti e poco apocalittici?
Lascio a voi la risposta, visto che da recensore mi sono presuntuosamente inserito in questa schiera di scrittori “imputati”.
Comunque sia, resta che il debutto del Cave narratore, E L’Asina Vide l’Angelo, benché più slegato e legnoso come impianto romanzesco, lasciava in bocca un gusto più intenso e partecipato di Bunny Munro.
Leggete e dite la vostra.
Mario


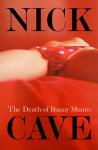

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.