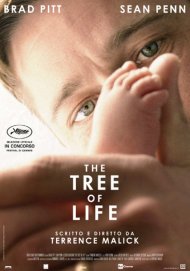"We're happy, Ma, we're having fun
The train ain't even left the station (oh, children)
(Hey, little train, wait for me)
(I once was blind but now I see)"
(Nick Cave, O Children)
Lui e lei.
Due giovani americani sperduti in una misteriosa stazioncina in Spagna.
A bere qualcosa nel piccolo bar mentre attendono un treno che non arriverà, per l'intera durata del racconto/spettacolo.
Una "deliziosa birra fresca" o un "Anis del Toro", bibita locale scoperta da lei grazie a una pubblicità sulla tenda di bambù della porta del bar?
Qualunque cosa, anche se "sa di liquirizia, come "Tutte le cose, in particolare, che si sono aspettate tanto", dice lei.
Del resto, "È tutto quello che facciamo, no? Guardare cose e assaggiare nuove bibite".
 Tutto pur di non affrontare quel nodo che sta in gola ad entrambi e che nessuno dei due nomina mai, fino alla fine: lei (probabilmente, anche se appunto non viene mai detto) è incinta. Lui vorrebbe farla abortire una volta giunti in città. Dice solo che sa che "È davvero un'operazione semplicissima".
Tutto pur di non affrontare quel nodo che sta in gola ad entrambi e che nessuno dei due nomina mai, fino alla fine: lei (probabilmente, anche se appunto non viene mai detto) è incinta. Lui vorrebbe farla abortire una volta giunti in città. Dice solo che sa che "È davvero un'operazione semplicissima".
Lei non è convinta, del resto sarà su di lei quell'operazione semplicissima, mica su di lui.
Ma, soprattutto, comunque vada, anche se lei si dice disposta a fare qualunque cosa per lui, qualcosa si è rotto fra loro.
E lei lo sa, lo sente: anche se venisse rimosso quell'ingombro non voluto, le cose non "torneranno come prima", come chiede lei ingenuamente.
Non ritorneranno felici com'erano prima. Perché quando quel qualcosa si è spezzato, "quando te l'hanno portato via, non riesci a riaverlo mai più".

 Questo è tutto: trama, testo, senso. Il racconto di Hemingway, data - apprendiamo - al 1927 (QUI lo leggete completo) e fu pubblicato nella monumentale raccolta I quarantanove racconti del 1938 (sopra, l'autore circa a quell'epoca): scarno fino all'osso, un capolavoro della "tecnica dell'iceberg" dello scrittore americano per eccellenza, in cui ciò che si vede (il dialogo fra i due protagonisti) è un frammento insignificante di una montagna che però il narratore ci obbliga ad intuire tenendocela celata, così anticipando genialmente di quasi 80 anni il Sunset Limited di Cormac McCarthy, ma anche Raymond Carver e i minimalisti ovviamente.
Questo è tutto: trama, testo, senso. Il racconto di Hemingway, data - apprendiamo - al 1927 (QUI lo leggete completo) e fu pubblicato nella monumentale raccolta I quarantanove racconti del 1938 (sopra, l'autore circa a quell'epoca): scarno fino all'osso, un capolavoro della "tecnica dell'iceberg" dello scrittore americano per eccellenza, in cui ciò che si vede (il dialogo fra i due protagonisti) è un frammento insignificante di una montagna che però il narratore ci obbliga ad intuire tenendocela celata, così anticipando genialmente di quasi 80 anni il Sunset Limited di Cormac McCarthy, ma anche Raymond Carver e i minimalisti ovviamente.
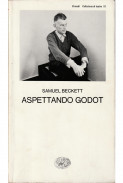 Anche quell'aspettar Godot del Beckett che sarebbe arrivato solo nel 1952. Ma che si sente nella raffinata, essenziale regia di Paolo Bignamini (per una produzione di Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Teatro de Gli Incamminati, Franco Parenti stesso e Università degli Studi di Milano) che mette in scena - con la drammaturgia di Maddalena Mazzocut-Mis - solo i due interpreti Federica D’Angelo e Matteo Bonanni (foto a lato, bravi ed efficaci a dispetto di qualche minimo inciampo, ma in fondo sono due che non si capiscono, no?).
Anche quell'aspettar Godot del Beckett che sarebbe arrivato solo nel 1952. Ma che si sente nella raffinata, essenziale regia di Paolo Bignamini (per una produzione di Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Teatro de Gli Incamminati, Franco Parenti stesso e Università degli Studi di Milano) che mette in scena - con la drammaturgia di Maddalena Mazzocut-Mis - solo i due interpreti Federica D’Angelo e Matteo Bonanni (foto a lato, bravi ed efficaci a dispetto di qualche minimo inciampo, ma in fondo sono due che non si capiscono, no?).
Con lui che le gira intorno posizionando quattro microfoni e tre faretti come se fosse il tecnico di scena della rappresentazione di lei sola, che snocciola il racconto filato nella sua forma letteraria, cioè recitando anche le frasi di lui.
Poi prende la parola lui e lo ripete tutto a modo proprio, coi propri toni e dicendo anche le frasi di lei, espediente che - oltre a salvare la forma letteraria originale per la gioia degli scrittori (!) - rende a meraviglia il non-dialogo che si svolge fra i due innamorati lacerati. Quel vaniloquio su bibite e "colline come elefanti bianchi", da cui appunto è stato rimosso il grumo inesprimibile e la cui poesia ormai non renderà più felice nessuno dei due. Poi il breve testo verrà ripetuto una terza volta con un'interazione fisica più intensa, finalmente davvero drammatica fra i due. Infine una quarta con l'ordine dei blocchi concettuali un po' alterato, di modo che il dialogo si chiude a loop sulla banale frase con cui era iniziato: "cosa prendiamo?"
Breve, intenso, angosciante. Anche nella minimale colonna sonora, composta solo dalla sopra citata O Children di Nick Cave & The Bad Seeds (da Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus del 2004) e da uno strumentale per solo violoncello di Jóhann Gunnar Jóhannsson, autore di molte colonne sonore cinematografiche (tra cui Arrival di Villeneuve e Madre di Aronofsky).
Se siete fra quelli che si chiedono "che senso abbia ancor oggi andare a teatro" quando il cinema (o la tv) possono benissimo offrirci le stesse pietanze, anche con maggior potenza visiva, andate a vedere Colline come elefanti bianchi al Parenti (fino al 3 luglio, poi il 9 sarà al Centro Teatrale Bresciano).
Capirete che un senso c'è ancora.
Anche se, come dice Jig (lei), "non possiamo più riavere tutto".
Non com'era prima.
Mario G.